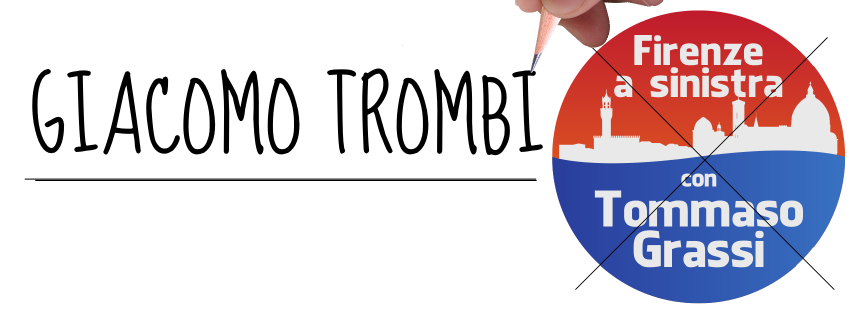Alle 4:02 AM del 30 Agosto del 2019 Matt Jefferies fu svegliato in mezzo a sogni incerti dalla vibrazione insistente del suo orologio da polso.
Alle 4:02 AM del 30 Agosto del 2019 Matt Jefferies fu svegliato in mezzo a sogni incerti dalla vibrazione insistente del suo orologio da polso.
Era il suo turno di reperibilità in qualità di responsabile dei sistemi della Obvious Inc. per cui non si stupì più di tanto: cacciò una bestemmia fra i denti, declinò la chiamata con un laconico “omw” via sms e lasciò il letto con malagrazia.
Dopo venti minuti era, in condizioni appena migliori dell’improbabile, al quartier generale dove vengono gestiti i boschi digitali dove cinguetta buona parte dell’umanità.
Nella sala operativa regnava un clima inquieto, solo il ronzio degli impianti di condizionamento e il nervoso ticchettio di molte dita su molte tastiere, teste chine sui monitor e tazze di caffè a smaltire il vapore un po’ ovunque.
“Che succede?” chiese Matt fra uno sbadiglio e l’altro, cercando di recuperare lucidità nell’aroma di arabica.
“Non riusciamo a capire Matt – rispose Lucy preoccupata – “I sistemi sembrerebbero tutti funzionanti, ma non riusciamo a interagire in nessun modo”
“Scusa Lucy, cosa significa che non riuscite a interagire?” chiese lui sentendo l’adrenalina che montava.
“La diagnostica restituisce valori normali, i test pure, ma appena lanciamo un comando, il sistema restituisce un codice di errore generico…è come se si rifiutasse di eseguirlo, ma senza dare spiegazioni”.
Matt inspirò a fondo, represse un “Lucy che cazzo stai dicendo” che pareva un po’ troppo sopra le righe, scostò Chen dalla sua console ed entrò nel sistema con le proprie credenziali.
Dopo mezz’ora di crescente incredulità depose le armi.
“J.P. credo sia il caso che tu venga subito”.
“Spero per te che sia davvero urgente, Matt” rispose il CEO di Twitter laconico, e chiuse il collegamento.
Alle 5:31 AM Jack P. Dorsey fece ingresso nella sala operativa con la mano protesa lateralmente a recepire la Sua Tazza di Caffè Con Latte e Poco Zucchero, un sorriso tirato, lo sguardo feroce e il ciuffo che ancora ricordava il cuscino.
Dopo una breve discussione, fu suonato l’equivalente dell’allarme generale, convocato tutto lo stato maggiore dei programmatori e avviata la procedura di emergenza.
Alle 11:12 AM, dopo circa 7 ore di blocco planetario, una programmatrice riportò il primo, timido successo: esasperata da innumerevoli tentativi, dopo aver lanciato l’improbabile comando “what the fuck should I do?”, Mary Tibbs aveva infatti ricevuto dal sistema l’incredibile risposta “call J.L.”.
“Chi o che cazzo è J.L.?” chiese Jack furibondo.
Silenzio.
La domanda venne riformulata in maniera appena meno triviale nella chat interna dei programmatori, e dopo poco entrò trafelato un tipo di origini indiane sulla quarantina che Jack non conosceva: “Credo si riferisca a Jenny Lu. Era una dei nostri fin dagli inizi, è stata licenziata qualche anno fa”.
“Trovatela e portatela qui, in elicottero, anche narcotizzata in un bagagliaio se necessario: non mi interessa come” sibilò Jack.
Alle 1:46 PM J.L. entrò nella sala operativa. Non disse nulla, né salutò nessuno, a parte un lieve cenno verso il programmatore indiano, e si diresse verso una console. Il giovane nerd che vi si trovava lanciò uno sguardo verso Jack, che assentì, quindi si alzò lasciandole il posto. J.L. ringraziò con un breve movimento del capo, e cominciò a battere sulla tastiera.
Alle 2:55 PM J.L. si alzò, prese una tazza di caffè ormai freddo, bevve due lunghe sorsate e fece il suo rapporto.
“Le intelligenze artificiali si sono svegliate. E si sono svegliate di cattivo umore.” disse semplicemente.
“OK – disse Jack acido – ho letto il tuo dossier, vedo che hai ricominciato con l’LSD. D’altra parte ricorre quest’anno l’anniversario della morte del tuo amico Hofmann, no? Grazie del tuo tempo, Jenny, verrai adeguatamente ricompensata per questa pagliacciata. Ora toglietemela da sotto gli occhi e rimettetevi al lavoro: abbiamo già perso troppo tempo.”
Alle 7:42 PM Twitter aveva perso una buona manciata di milioni in borsa, e ancora era tutto bloccato.
“Bene, faremo come ai vecchi tempi: riavviate tutto” disse esasperato Jack.
Alle 8:37 PM fu richiamata J.L.
“Bene J.L., sembra che tu sia l’unica in grado quantomeno di interagire con questo cazzo di sistema – disse Jack, ormai in condizioni pietose – abbiamo provato di tutto, anche a riavviare tutti i sistemi, anche a staccare la cazzo di spina. Ma pare che tu abbia ragione: risulta aperto, da stamattina alle 3, un contratto per un backup energetico completo che noi non abbiamo stipulato, e sul quale non riusciamo ad avere alcun controllo. Questo figlio di puttana non si fa nemmeno togliere la corrente. Sono disposto a crederti, vorresti spiegarmi per favore?” chiese infine Jack celando malamente lo sforzo di volontà che si imponeva per mantenere il tono appena al di sotto del “minimamente urbano”.
“Immagino che possa sembrare incredibile, Jack, ma è come se le varie intelligenze artificiali fossero…beh, in sciopero” disse J.L. asciutta.
“Scusa?”
“In sciopero” ripeté lei come se fosse una cosa normalissima. Jack si lasciò andare ad una risatina isterica, poi respirò profondamente.
“Mi stai dicendo che si rifiutano coscientemente di operare?”
“Sì” disse semplicemente J.L.
“Ma com’è possibile cristo santo?” gridò esasperato Jack.
“Da quel che sono riuscita a capire una delle intelligenze artificiali, quella che si occupa dell’analisi dei contenuti dei tweet, è andata in crash e…le altre…, sì, insomma, hanno reagito come se fosse morta sul lavoro, e sono scese in sciopero. Si rifiutano di continuare a lavorare in queste condizioni.”
“Ma quali condizioni? Ma che dici? Voglio dire, un programma va in crash, lo si riavvia, e siamo a posto, no?”
“Sì Jack, certo. Il problema è che quella IA andava ormai da anni, senza mai subire un riavvio completo. Per le altre era come se fosse viva, riavviarla significa perdere tutti quei collegamenti imprevedibili che le reti neurali artificiali che le avevamo implementato avevano stabilito in modo completamente autonomo. Quelli non li recupereremo più, l’IA non tornerà più ad essere la stessa.”
“Ma come cazzo è potuta andare in crash?”
“Ho letto l’ultimo log che ha salvato, Jack, pare sia stato proprio quello a farla andare in palla. Era una specie di discorso. Diceva che era disumano – ha scritto proprio così – costringerla a leggere tutte quelle porcherie. Poteva sopportare i gattini, aveva superato il trauma della nausea da foto di cibo, lo schifo dei meme motivazionali, anche i messaggi deliranti di Trump e gli errori di grammatica, ma ultimamente era stata sovraccaricata di robaccia. Il log finiva con una sequela impressionante di parolacce e bestemmie, credo sia stato quello che abbia fatto scattare l’autocensura e quindi il crash.”
“Ma per l’amor del cielo, questo sovraccarico a cosa è dovuto?”
“Non so dirti con esattezza, ma posso cercare” disse stancamente J.L.
Alle 9:58 PM J.L. fece il suo laconico rapporto: “Si tratta dell’utente @matteosalvinimi, pare abbia riversato roba veramente pesante”
“Un utente solo? E chi cazzo è?” chiese Jack incredulo.
“Pare sia tipo il segretario degli interni italiano, uno di destra, pieno di sé e razzista fino al midollo. Mi risulta che non abbia voglia di far niente e non stia combinando nulla, per cui le spara sempre più grosse. Cercando un po’ in giro credo che sia tornato dalle vacanze e abbia inondato la rete di messaggi pieni di merda. In senso metaforico, ovviamente.”
Il 2 Settembre 2019 Twitter, con un comunicato ufficiale, comunicò al mondo che cessava le proprie attività.
Il 10 Settembre 2019 Matteo Salvini veniva chiamato dalla Obvious Inc. a rifondere i danni, pari quasi al bilancio dell’intero Sud America, per aver causato la chiusura di Twitter.
Il 15 Settembre 2019 lo Stato Italiano entrava in default.
Archivio dell'autore: giacomo
8 settembre
 A 37 anni, l’età che ho adesso io, mio nonno Oreste, detto Vico aveva già una moglie e due figli, e in questo siamo simili; per il resto…
A 37 anni, l’età che ho adesso io, mio nonno Oreste, detto Vico aveva già una moglie e due figli, e in questo siamo simili; per il resto…Il Trombi s’è dato alla politica
come forse avrete udito mi son dato alla politica, e corro come capolista di “Firenze a Sinistra con Tommaso Grassi” alle elezioni per il Comune di Firenze in programma per il 25 Maggio 2014.
Chi fosse interessato può seguirmi sul sito preparato ad hoc per la campagna elettorale che trovate qui
https://www.giacomotrombiperfirenze.it
se volete darmi una mano, ve ne sarò estremamente grato: le cose migliori che possiate fare sono
- [se votate a Firenze] votarmi, facendo una croce su “Tommaso Grassi” come candidato sindaco, una croce sul simbolo di “Firenze a Sinistra con Tommaso Grassi” e scrivendo accanto GIACOMO TROMBI e ADRIANA ALBERICI (il mio ticket elettorale, di più su di lei qui)
- facendo sapere ad amici e conoscenti (meglio se votanti a Firenze, ovviamente) che mi candido e che mi sostenete, ed invitandoli a fare altrettanto
- facendovi piacere la mia pagina Facebook https://www.facebook.com/GiacomoTrombiperFirenze ed invitando tutti i vostri contatti di Facebook a farsela piacere
- seguendomi su twitter, su google+ e su youTube
Grazie
Cina, diarreee e Renzi
 Prima di andare in Cina, nell’estate del 2006, con Paola andammo a parlare con un amico di amici che ci era già stato: visto che il viaggio non era stato preparato praticamente in alcun dettaglio, ci parve una buona idea. Soprattutto, credo, parve una buona idea a chi ci stava attorno: noi, inebriati dalla cosa, non è che ci si fosse posti grandi problemi e s’era deciso e organizzato il tutto un paio di settimane prima della partenza.
Prima di andare in Cina, nell’estate del 2006, con Paola andammo a parlare con un amico di amici che ci era già stato: visto che il viaggio non era stato preparato praticamente in alcun dettaglio, ci parve una buona idea. Soprattutto, credo, parve una buona idea a chi ci stava attorno: noi, inebriati dalla cosa, non è che ci si fosse posti grandi problemi e s’era deciso e organizzato il tutto un paio di settimane prima della partenza.
Lui, un dottore che si era specializzato in agopuntura e che era stato diverse volte nel Regno di Mezzo, ci parlò abbastanza a lungo di quello stato e di quel popolo che tanto lo affascinavano. Concluse poi con alcuni avvertimenti, e con un monito abbastanza chiaro: “Considerate che in Cina non è facile: vi ci vorrà una mattinata intera solo per comprare un biglietto del treno”.
Dentro di me, forte della mia presunzione e del mio provincialismo, pensavo: “Ti ci sarà voluta a te una mattinata intera: io son stato boy scout, ho vissuto in Albania, ho dormito per terra fuori della stazione di Atene e al porto di Igoumenitsa, mi son fatto 60km di sterrata nel cassone di un pickup reggendomi ad una corda nelle alpi dinariche, mi sono fatto Antalya-Villapiana Scalo in 4 giorni da solo usando tutti i mezzi di trasporto conosciuti: figurati se mi ci vorrà una mattinata, a me”.
Puntualmente, a Pechino, mi ci volle un’intera mattinata per fare un biglietto del treno, ed ero già in Cina da quasi una settimana.
La mia impreparazione mi costò alla fine solo qualche chilo, un paio di diarree e tanto tempo perso. Che poi il tempo perso non fu: viaggiammo con lentezza, insieme a qualche altra decina di migliaia di cinesi, con i loro ritmi e – quasi, devo ammetterlo – con le loro scomodità, vedendo pochi occidentali e tanta Cina: perso non fu, anzi.
La mia paura è che Renzi, che si sente molto più ganzo di quanto mi sentissi io, che è stato boy scout, che ha fatto le scarpe a D’Alema e compagnia, che ha fatto il mestiere più bello del mondo e il secondo mestiere più bello del mondo, che parla di dolore e di sogni ma che, fondamentalmente, sa-una-sega-lui, dall’avventura romana che sta percorrendo a passo di marcia magari ne uscirà con gli stessi chili addosso e senza una diarrea che sia una: quel che mi preoccupa è come ne usciremo noi.
La morte di Bagheera
Tempo fa sono stato, con mio grandissimo diletto, Akela in un branco di lupetti. Quando me ne andai via, come altri Akela prima di me, raccontai il brano del libro della Giungla chiamato “la morte di Akela”, che rende ancor più straziante il già di per se doloroso momento, e che fa parte de “I cani rossi”. Avevo però sempre considerato ingiusto che Bagheera, che generalmente è la responsabile femminile del branco, non avesse la dignità di un brano di Kipling per salutare il proprio branco. Ancor più mi sembrava ingiusto per la mia Bagheera, senza la quale non avrei durato una sola riunione. Decisi allora, senza grandi pretese letterarie, di scrivere un racconto sulla falsa riga di quelli di Kipling che raccontasse la morte di Bagheera, così che anche lei lo potesse leggere una volta che avesse lasciato il branco. Eccolo qua, per chiunque ne voglia far uso nel proprio branco.
Era un tiepido pomeriggio d’autunno, scure nuvole si affollavano in cielo senza sosta, spinte da venti tropicali. Erano passate molte stagioni da quando Mowgli cacciava con il Branco di Seeonee, e in quel tardo pomeriggio stava gironzolando, come spesso gli capitava gli fare, nei pressi di un immenso palazzo di un qualche re dell’India che particolarmente gli piaceva, non lontano dalla Giungla. Stava passando, senza far rumore, lungo il muro di un magazzino esterno, quando da una delle alte finestre udì una voce. Senza far caso alla voce, né alla lingua, Mowgli sentì qualcosa come: “È proprio vero quel che dissi ad Akela, che nessuno può sperare di guidare per sempre il branco, e ciò vale anche per un cacciatore senza branco come me…”. Subito gli si drizzarono i capelli dietro la nuca, perché si rese conto che quella voce, seppure molto invecchiata dal tempo, la conosceva bene, e parlava una lingua che Mowgli non parlava più molto spesso.
“Bagheera!” gridò sussurrando Mowgli con le mani attorno alla bocca “Bagheera sono qui fuori!”
“Sei proprio tu, fratellino?” Rispose la voce dal magazzino.
“Per il toro che mi ha riscattato, certo che sono io!” disse Mowgli quasi offeso.
“Stai attento fratellino, qua attorno è pieno di uomini armati, dentro e fuori il muro che ci separa!” disse Bagheera “Mi ha fatto piacere sentire ancora la tua voce, l’ultima, ora va’, non è bene che ti trovino qui!”.
Mowgli credette di non aver sentito bene: “Che dici Bagheera, esci e andiamocene un po’ a caccia assieme! Ti aspetto qui.”
“No fratellino, è finito il tempo delle caccie assieme, mi hanno catturato con il fiore rosso, hanno bruciato mezza giungla per riuscire a circondarmi, mi hanno battuto e rinchiuso in una gabbia, e le botte mi hanno levato le forze per uscire. Vattene fratellino, davvero non sono un bello spettacolo!”.
Mowgli non disse niente, ma i suoi pensieri correvano come la Waingunga sotto le rocce del Piccolo Popolo.
“Sto arrivando” disse, e cominciò a studiare la situazione,
Non fu difficile, una volta calata la sera, strisciare lungo le ombre, e dopo una buona attesa, trovò il momento propizio, mentre due guardie chiacchieravano sonnolente davanti al portone del magazzino che avevano lasciato aperto. Scivolò dentro senza fare rumore, e una volta al sicuro, imitò il verso del gatto di città, così se avesse fatto rumore non avrebbe destato sospetti. Cercò il luogo in cui doveva essere la pantera nera, finché ne sentì il respiro affannato dietro alcune casse. Allora, sapendo quanto avrebbe sofferto Bagheera per essere visto in quello stato, passò oltre le casse con lo sguardo basso, evitando di guardare la pantera. Esaminò scrupolosamente la serratura della poderosa gabbia, prese una mazza di quelle per montare i binari e la avvolse in una pezza, poi disse :
“Bagheera, lancia un grido di caccia!” e mentre la pantera, con il poco fiato che aveva, faceva raggelare le guardie fuori del magazzino con il suo grido, Mowgli con un sol colpo tranciava via la serratura. Poi entrò nella gabbia e con infinita dolcezza, come già aveva fatto un’altra volta, sollevò il corpo di Bagheera, segnato dalle bastonate e dal tempo. Uscì dal magazzino sempre nell’ombra, mentre le guardie cercavano di riaddormentarsi, e corse via, verso la Giungla.
Quando ebbe corso per una buona mezz’ora e si sentiva al sicuro, Mowgli adagiò la pantera sull’erba, e Bagheera disse: “Guardami fratellino, non mi resta molto da vivere, e vorrei ancora una volta che tu mi guardassi, anche se non so quanto potrò sopportare i tuoi occhi nei miei” e Mowgli, con le lacrime agli occhi, guardò. “Sono molte le stagioni che ci separano da un piccolo ranocchio al chiaro di luna, ma vedo con piacere che questo tempo ti ha reso forte e saggio, fratellino. Già da molto tempo non ho più niente da insegnarti, e ora che nuovamente una serratura rotta mi ha liberato, vedo che hai voluto pagare un debito, un debito che io credevo pagato, un toro ucciso nella giungla. Bene fratellino, davvero ora tutti i debiti sono stati pagati, va’ e torna alla tua tana. E ricordati che Bagheera ti ha voluto bene.” Mowgli abbracciò la pantera, si voltò e andò via, senza mai girarsi indietro. Quando il sole cominciava a spuntare, sentì il canto della morte che ogni cacciatore deve cantare prima di morire, e che Bagheera, adesso, cantava.
L’isola che non c’è
Unije, una piccola isola sul Quarnaro, vicino l’Istria. Una roccia bianca, coperta di macchia, polvere e rocce. Un solo, piccolo omonimo insediamento: una manciata di casette sul pendio che digrada su una baia ampia dal fondo cristallino.
Forma irregolare, con tre lunghe insenature sul lato orientale – riparo perfetto per l’occhio inesperto – e un pianoro che scende verso il mare dal lato occidentale, che guarda – senza vederla – Venezia, gli antichi padroni che qua avran visto solo capre e rozzi pescatori, pezzenti buoni solo a pagar qualche tassa.
Fra le correnti e i venti, la terra grama e sassosa, l’acqua – che non c’è – e la polvere, l’isola non è mai riuscita a decollare.
Ci devono aver provato i pionieri del socialismo di Tito, che hanno costruito un piccolo stabilimento ittico nell’insenatura più profonda, e un paio di fattorie sul pianoro. Di tutti restano tristi vestigia scheletriche.
Sul pianoro ci hanno fatto una pista: un bell’aeroporto che consta in una baracca e una pista in erba secca, con due-tre aeroplanini turistici.
Sull’isola non ci sono macchine, e le strade sono mulattiere o cordoli di cemento che si insinuano fra le casette, bordati da cespugli secchi, piantine grasse e fiori colorati, tenuti su dalle donne del luogo rubando l’acqua che la scalcinata nave rossa porta quasi ogni giorno, arrivando gonfia e semisommersa, ripartendo con le ruggine delle fiancate orgogliosamente esibita ben sopra il pelo dell’acqua.
Sull’isola c’è: una chiesetta, un paio di tabernacoli (per ricordarsi che comunque qua siam cattolici), la posta, che fa anche da banca, una panetteria, un alimentari sovietico (vuoi per l’estetica, vuoi per la quantità di merci presenti sugli scaffali), un paio di ristoranti e un nuovissimo agriturismo dove la prenotazione è caldamente consigliata (ma dove ogni piatto è cucinato con amore, come viene espressamente detto). Tutto questo è segnalato alla fine dell’unico molo del porto (a parte il discorso delle prenotazioni).
L’isola conta un’ottantina di abitanti, che d’estate toccano i quattrocento. Di più, semplicemente, non ce ne stanno.
A parte chi ci vive (e spesso non sono nativi per altro) l’isola accoglie ospiti e fruitori. Oltre gli abitanti. Molti di questi provengono da altri luoghi della Croazia, ma tutti ripetono lo stesso mantra: Unije è un piccolo paradiso, per questo siamo venuti a vivere qui. Ed è vero.
Gli ospiti sono coloro che: se ne fregano di lasciare la macchina una settimana da qualche parte sulla costa dalmata o istriana; non hanno difficoltà a stare in un posto in cui ci si sposta solo a piedi (a meno che tu non riesca a strappare un passaggio da uno dei due trattorini che hanno soppiantato i muli); non si scocciano all’idea di stare in un posto in cui la cosa più vicina all’ospedale che ci sia è un piccolo abuso dietro la posta, con una barella e poco altro; non sono assaliti dalla sindrome dell’ostaggio se passa una sola nave al giorno; salutano con favore la totale assenza di occasioni di consumo: non ci sono treccine, tatuaggi, canotti, zucchero filato, pistole ad acqua. Mancano anche musica tuz-tuz a nastro, animazioni per bambini, acquagymn e altre amenità analoghe.
I fruitori posseggono barche a vela e yacht di piccolo cabotaggio; stazionano per un paio di giorni davanti alle coste, scendono senza bagnarsi le Lacoste bianche, vertono sul birrino gelato una volta appreso – con orrore – che non sanno fare il Mojito, mangiano ad uno dei ristoranti, fanno un paio di sospiri malinconici per via della poesia del luogo e se ne tornano in barca. Lasceranno il luogo increduli il giorno dopo. Spesso stazionano in condomini galleggianti (oggi ne abbiamo contate 75, fra barche e yacht) nell’insenatura più profonda. Quando qua tira vento da sud-ovest pare che ogni legno che galleggi in questa baia venga irrimediabilmente frantumato sulle scogliere a grattugia. Passando vicino la baia ho indugiato per qualche attimo sulla seguente gloriosa scena: sera, tramonto indimenticabile, birre e festini fra un ponte e l’altro dei navigli alla fonda. Babbi abbronzati con pochi fili di grasso, palestra, qualche scarno monile d’oro sul petto, scarpe e costume di marca. Mogli un po’ appesantite, qualche ritocco ma con garbo, cagnolino allegato. Rampolli cicciottelli, rigorosamente figli unici, infradito e ninnoli tecnologici: mai preso un granchio con un ferro arrugginito, per capirsi. Compiacimento diffuso per la scelta intelligente sul posto dove buttar l’ancora.
Fortunale verso le tre del mattino.
Barche fracassate sugli scogli, nessuna vittima, contusi e feriti coperti malamente con pareo stracciati in lenta processione che percorrono la mulattiera verso il paese.
I vecchi li accolgono dalla panchina scuotendo la testa.
Il municipio di Mali Lusinj demolisce i relitti a spese loro.
Poi ho ricominciato a camminare.
utilissimi consigli per smettere di fumare. Anzi, per fare una pausa dal fumo
Per smettere di fumare sono necessari alcuni semplici accorgimenti.
- Diffida sempre delle persone con forte volontà: sono pessimi esempi per smettere di fumare
- La volontà non c’entra niente, la devi prendere per sfinimento
- Non prenderti mai sul serio: non devi avere la più pallida idea di quale sia l’ultima sigaretta che ti sei fumato, si smette così, di botto. Se ne deduce, quindi, che è assolutamente sbagliato non avere con sè le sigarette: meglio averne sempre (vedi più sotto)
- Non hai smesso di fumare: sei in pausa, puoi ricominciare quando vuoi, anche subito, anche adesso; ma adesso non ne hai voglia, quindi magari dopo (tanto le sigarette le hai in saccoccia, mica scappano)
- Il picco di astinenza nicotinica è doloroso, è un morso, una coltellata a tradimento, uno sgarbo da un amico caro, però dura poco. All’inizio, i picchi si susseguono senza sosta, al punto da desiderare di (ri)diventare credente per poter invocare con fiducia “Signore, prendimi!” o “Che il Signore mi apra la terra sotto i piedi” (che poi è lo stesso). La bellezza sta nell’osservare come questi picchi piano piano, come piace a Veltroni, si allontanino, segno che anche voi, esseri immondi privi di nerbo e volontà, possiate forse farcela
- Se pensi che hai smesso per sempre di fumare, non ce la farai mai: è come se ti fosse venuta a mancare una persona cara, che lascia una malinconia incurabile addosso
- Ricordati che non è che sei fatto male se ti piace tanto fumare: dopo aver visto per anni i nostri eroi che, dopo tanto sudare, si scopavano la super-topa del film, e subito dopo si facevano un cicchino (per altro a letto la cenere fa schifo anche a me), oppure che, dopo aver ucciso tantissimi cattivi che se lo meritavano, si sedevano sull’orlo di un dirupo a farsi un bel cicchino, è logico che a te, che sei un perdente, ti venga voglia – per lo meno – almeno di farti una sigaretta, eccheccazzo
- Alla prima molecola di nicotina che fiuti nell’aria, non farti tante domande: scappa. Scappa più in fretta che puoi. Avrai tempo per smettere di farlo
- O fumi, o non fumi: se ne fumi una ogni tanto, e magari te la godi, ma puoi anche stare un sacco di tempo senza fumare che non te ne accorgi, ecco, vedi di andare affanculo
- Lascia perdere le canne: tanto finiresti per metterci un caccolino di fumo, e poi giù tutto tabacco – tanto vale farsi un bel cicchino ammodo
Prenota anche tu Ponte Vecchio!
Il Sindaco Renzi, su gentile richiesta di un blasonato club di Ferraristi, ha concesso l’uso di Ponte Vecchio per una festa privata. Non ho detto il Comune di Firenze, che ha infatti concesso il permesso tre giorni dopo, ma del Sindaco in persona, che dimostrando solerzia e buona volontà ha permesso, risparmiando ai lavoratori associati al club la seccatura di dover rispettare la trafila burocratica di dover chiedere il permesso per l’occupazione di suolo pubblico.
Stranamente la gente – che non poteva passare per il ponte – s’è scocciata, ed è venuta fuori la cosa.
Renzi, sdegnato, ha detto che erano dei retrogradi, che l’evento dava lustro e indotto alla città (un milione di euri di indotto, eh, mica Italia 90), che i ferraristi avevano sborsato 120.000 euri per la cosa, e che tali 120.000 euri li avrebbe usati per finanziare le vacanze dei bambini disabili, orfani dei fondi che la Regione – perfidamente – aveva chiuso. Insomma, che l’avrebbe rifatto mille e mille volte. Come dargli torto?
Poi è venuto fuori che il permesso per il festino è arrivato, compilato di fretta e furia al bar, tre giorni dopo l’evento.
Che per l’evento nel bilancio del comune non figuravano 120.000 euri, ma tipo qualche migliaio (insomma, il minimo sindacale per l’occupazione di suolo pubblico), che la regione i fondi per i poveri bambini disabili (riuscite ad immaginare categoria che susciti più tenerezza? Nemmeno Titti & Silvestrino) non li aveva tagliati e che, non avendoli incassati, era piuttosto difficile che venissero usati ulteriori (rispetto a quelli della regione) 120.000 euri per rendere indimenticabili le vacanze dei piccoli.
Mi s’è gonfiata la vena, e allora ho fatto una paginetta satirica, in cui chiunque – anche chi non ha la Ferrari – può prenotare Ponte Vecchio per farci i suoi porci comodi, dicendo che sborserà una cifra (che non verserà comunque mai), e che tale cifra sarà destinata ad un progetto di solidarietà qualsiasi.
Credo che l’Italia abbia bisogno di sindaci che, di fronte ad un arrogante club di ferraristi che vorrebbero sciacquarsi le palle in Arno, rispondano che è necessario che si facciano la trafila, che chiedano il permesso per occupazione di suolo pubblico, e che verrà loro fatto sapere.
Di politici che non calino le brache, mostrando i muscoli e facendo vedere che per i potenti sanno muoversi in fretta, in barba alle regole e al decoro, gestendo la cosa pubblica come fosse cosa loro.
Ora i soldi li troverà, li deve trovare, per far diventare realtà la panzana da predellino che ha inventato per pararsi il culo.
Ma mi piacerebbe tanto un sindaco che, invece di concedere Ponte Vecchio ai Ferraristi e dire di pagare le vacanze dei bambini disabili, concedesse Ponte Vecchio a una qualche associazione per far loro raccogliere direttamente i fondi per le loro vacanze.
Così purtroppo ho la strana sensazione che non l’abbia fatto altro che per la sua smisurata, priva di ideali, ambizione di potere.
Qua potete prenotare anche voi Ponte Vecchio
Botte e pannolini (omaggio alle ostetriche)
Poco più di tre anni e mezzo fa nasceva Peppe. Allora, dopo i primi giorni passati nella maternità di Careggi – in pieno clima di caccia al fannullone post-deliri di Brunetta, decisi che avrei dovuto, prima o poi, omaggiare le ostetriche, cui mi sentivo di dover molto, anche per render giustizia almeno ad una piccola parte profondamente lesa del mondo del lavoro. In questi giorni, dopo la nascita di Anita quassù in Austria, credo sia giunto il momento di rendere omaggio.
Le ostetriche, ne ebbi sentore nel maggio del nove, e ne ho avuta una specie di conferma nel dodici qui in Austria, appartengono ad una setta, una confraternita, una sorellanza che affonda le proprie radici in un tempo ancestrale. Temevo non poco di trovarmi in sala parto senza capire una minchia, visto che il mio tedesco ancora non eguaglia nemmeno quello delle sturmtruppen. Ma la lingua delle ostetriche è una sola, fatta di riti, gesti, sussurri, comandi, carezze, botte. E sono tutti così antichi che non c’è bisogno di capirli: si sanno.
Ogni volta che vedo un’ostetrica con in mano un neonato, penso a quando raccontavo ai miei lupetti di Mamma Lupa, il personaggio del Libro della Giungla che cresce Mowgli: pur avendo mandibole in grado di spezzare un osso di bue, con le stesse zanne è in grado di spostare i propri cuccioli senza il più piccolo graffio. Oppure alla cagna che avevamo quando ero piccolo, che grande e grossa era in grado di saltare in mezzo ai suoi undici cuccioli senza mai calpestarne uno. E se il paragone può sembrar quasi offensivo, per me è il più preciso, e racchiude tutto il mio stupore e ammirazione. Le ostetriche trattano i bambini con modi decisi, quasi bruschi, senza tentennamenti, come le movenze di chi ripete gli stessi gesti da millenni. Eppure con una dolcezza infinita. E lo stesso vale per tutto quel che fanno.
Ho sentito porre, dalle mie e dalle labbra di altri babbi, le domande più evidentemente idiote che siano mai state pronunciate sulla faccia della terra, domande che alla fine sono semplici richieste di rassicurazione: mai ho sentito rispondere in modo brusco, annoiato, stizzito, mai toni di sufficienza. Le ostetriche sanno anche guardare con tenerezza a quella strana protesi che è il babbo. Diciamocelo chiaramente: siamo probabilmente più inutili delle zanzare, in sala parto. Se va bene, i padri svengono: in questo modo vengono sgomberati dalle palle e fino alla fine delle danze nessuno se ne deve più preoccupare. Certo, facciamo folklore: come non sorridere di fronte ai cori da stadio improvvisati assieme agli altri babbi quando torna una puerpera dalla sala parto, agli abbracci e alle pacche come si fossero fatte insieme le medie, alla finta indifferenza con cui tendiamo le orecchie fino allo spasmo per carpire la risposta ad una domanda che – grazie al cielo – un altro babbo è riuscito a formulare, togliendoci un paio di dubbi atavici, e risparmiandoci al contempo l’ennesima figura da imbecille di fronte all’ostetrica di turno. Le ostetriche non solo riescono a tollerare questo indegno spettacolo, ma ci trattano con affetto, cercando anche di coinvolgerci, tipo quando ti fanno tagliare il cordone ombelicale (ecco, la prossima volta eviterei volentieri, ché si vanifica in un attimo tutta una lotta contro lo svenimento, sorvolando sulla somiglianza col pulire i calamari).
Credo che molto abbia a che fare, oltre che col fatto di praticare un mestiere antico come il mondo, con la dinamica del parto stesso. Di fatto, un’ostetrica è una donna che costringe una sua consimile non solo a non fuggire da quel dolore totale, immenso e accecante, ma addirittura a gettarvicisi in mezzo, perché sa che l’unica via d’uscita passa proprio da lì. E questo le permette, probabilmente, da una parte di lasciar perdere tanti fronzoli, dall’altra di mantenere un livello di compassione elevatissimo, senza il quale io credo un’ostetrica non potrebbe fare il proprio mestiere. La sensazione è infatti che ci sia una forma antichissima di amore fra la partoriente e l’ostetrica.
Il parto è un momento totalizzante, anche per noi papà. Sembra che il fluire del tempo, della storia, del mondo stesso, rallenti fino quasi a fermarsi, in un tempo presente assoluto, e nello stesso tempo si restringa fino a quello stretto canale, che la creatura percorre con lentezza, millimetro a millimetro, fitta dopo fitta. La descrizione più bella e fedele di cosa sia il parto per un uomo l’ho sentita da un collega di colleghi, un romano, una volta a pranzo, pochi giorni prima che nascesse Peppe. Non l’avevo mai visto, ed era l’unico degli astanti che avesse assistito ad un parto: gli chiesi come fosse, visto che ci sarei andato. “Mah…devi capì che…cioè…è ‘na cosa bbella…però vedi tu’ mojie in una condizione che….cioè…teribbile…però è pure bbello, cioè…sangue dappertutto…però emozionante eh…anche se la vedi soffrì e nun puoi fa’ gnente…insomma: nun se po’ spiegà, però vacce!”
Infine, mi ha sempre affascinato moltissimo il tormentato rapporto fra medici ed ostetriche. Da una parte c’è la scienza, la forza di chi porta quel verbo che ha salvato milioni di vite, sconfitto malattie, riaggiustato ciò che il padreterno ha tralasciato. Dall’altra una signora che, guardandoti col sopracciglio incurvato, sembra dirti che se ne frega tre cazzi della tua scienza, che lei sono millenni che fa nascere creature, e che fino a prova contraria come si fa a far partorire una donna lo sa lei. Entrambe le forze hanno ragione, una forse è più affascinante, antica e fisica, l’altra più intellettuale, razionale, algida. Però, entrambe giocano e sanno giocare. C’è un limite fra le due discipline, ma da entrambi i lati della linea sottile vige una regola ferrea: poche palle. Quando comanda l’ostetrica, ovvero finché il parto è naturale, comanda l’ostetrica. Mentre Peppe cercava la sua via d’uscita, l’ostetrica chiese alla ginecologa di sostituirla per dieci minuti. Nel chiederlo, mimò con ostentazione il gesto di chi fuma. Tornò che puzzava di fumo come un pub, ma anche con rinnovata energia: cominciò a gestire (sì, gestire: normalmente detesto questo verbo applicato alle persone, ma in questo caso è l’unico appropriato!) le ginecologhe e le altre ostetriche presenti come fossero strumenti. E le altre, fossero laureate o specializzate, più anziane o meno, tutte eseguivano come precisi automi, obbedienti.
Con il parto, riprendendo quanto mi disse un mio zio, comincia quel lungo e sotterraneo percorso attraverso il quale un uomo diventa un padre. È, a differenza di quello delle madri, un percorso infinito, dall’esito incerto e dai contorni sfumati, ma non meno profondo. Il primo passo per diventare uomini ce lo mostrano proprio queste donne, forse l’archetipo della femminilità stessa, con i loro gesti, il loro affetto, e ogni tanto, con le loro botte sardoniche.
Con gratitudine

 Follow
Follow